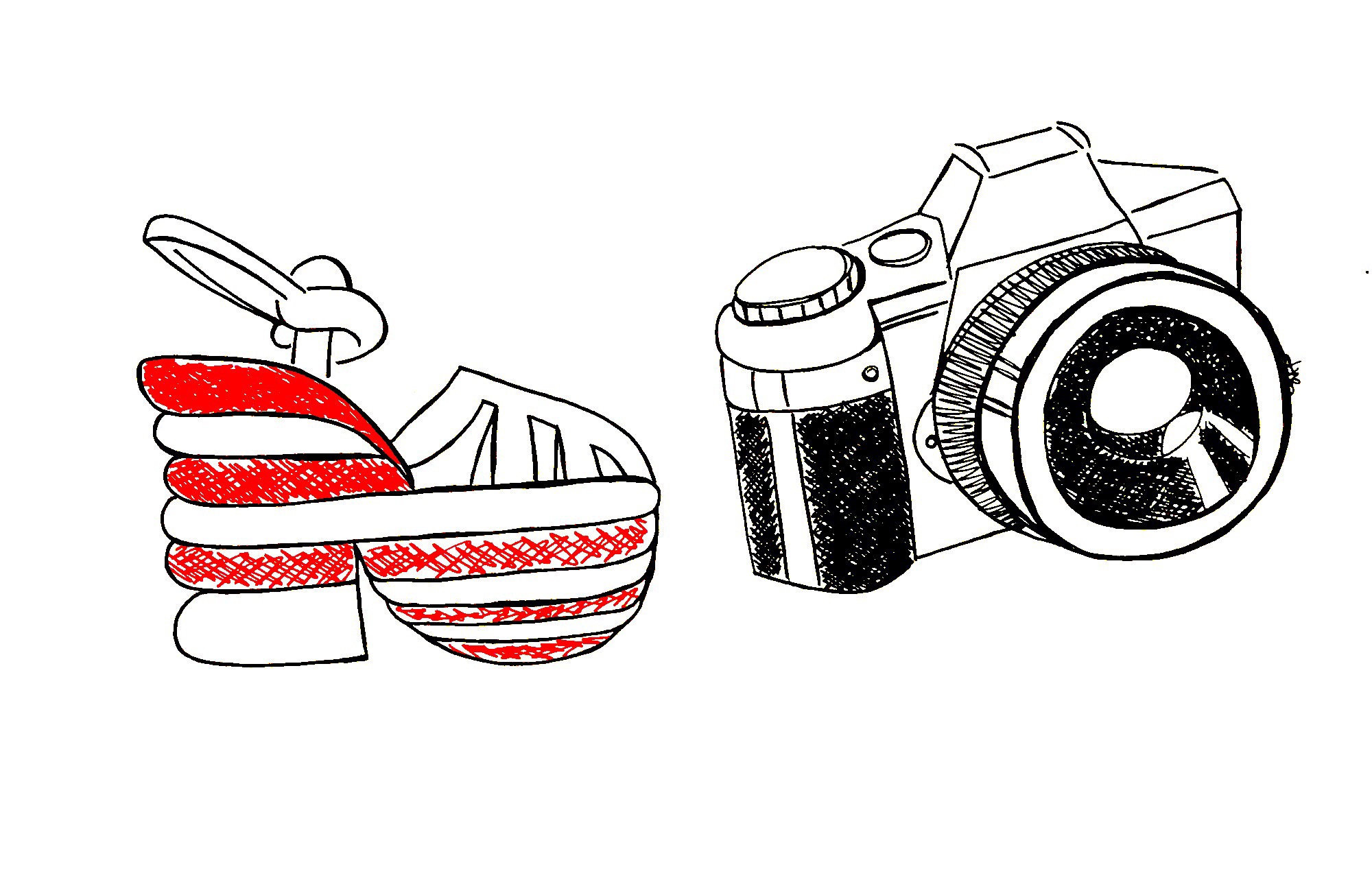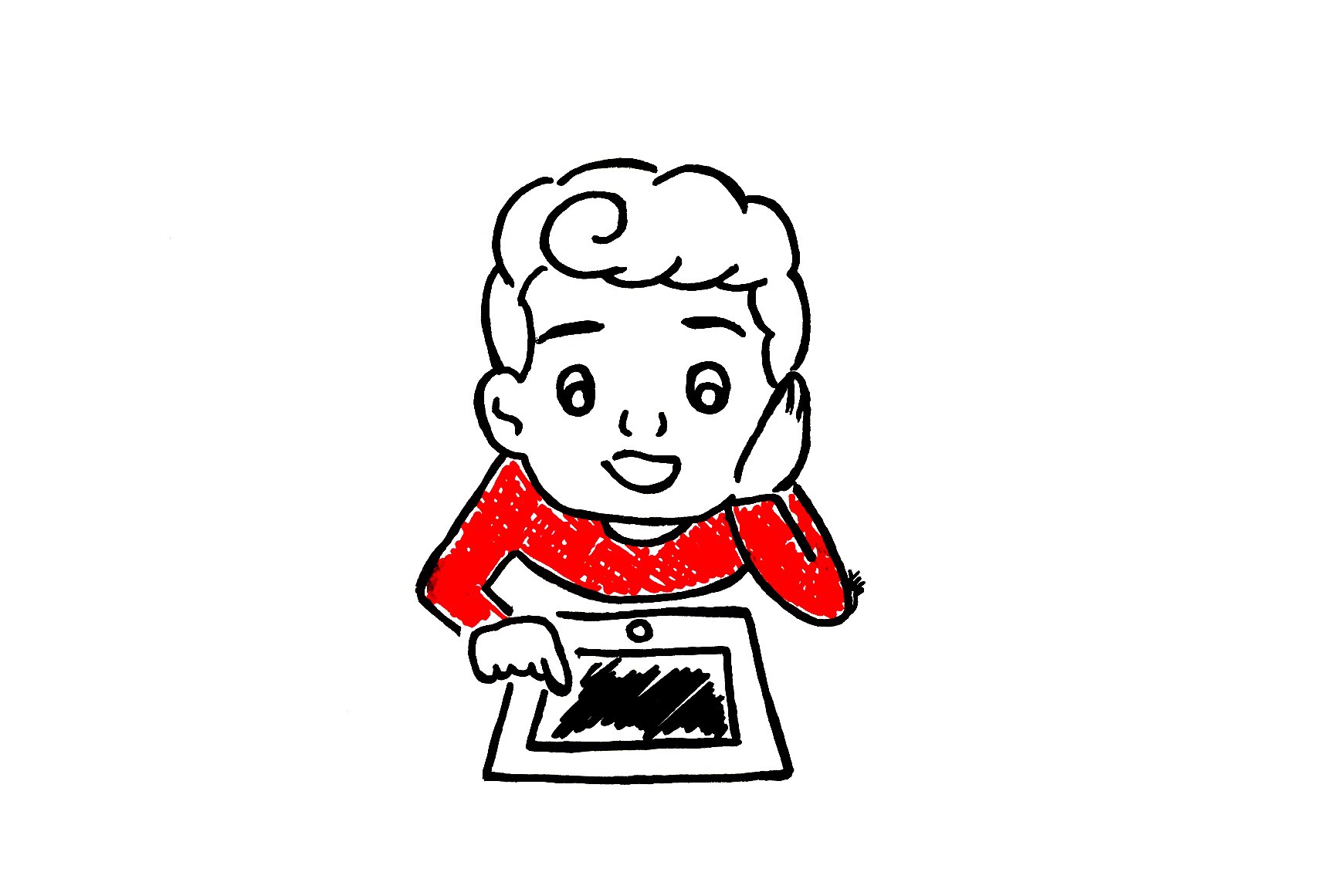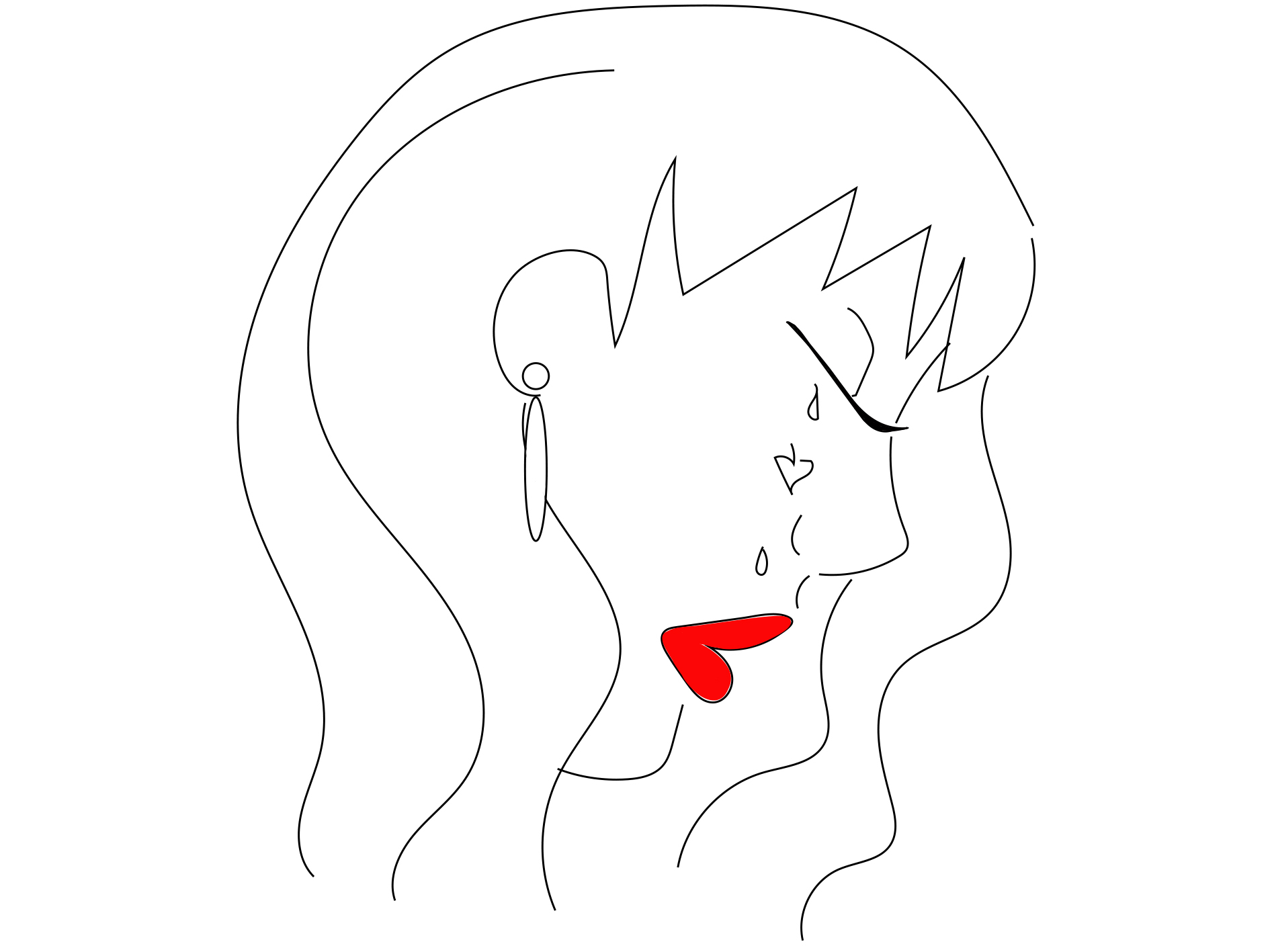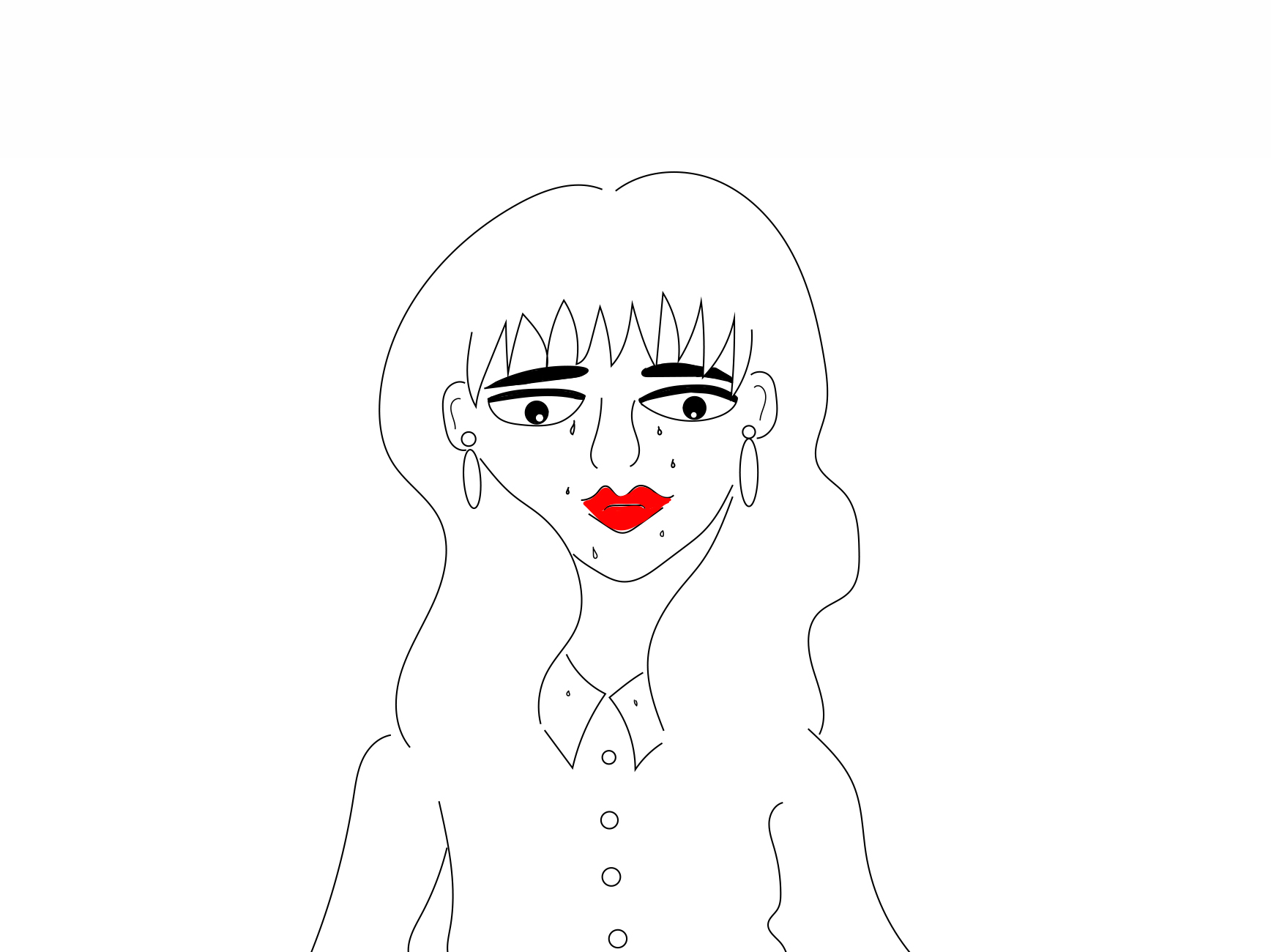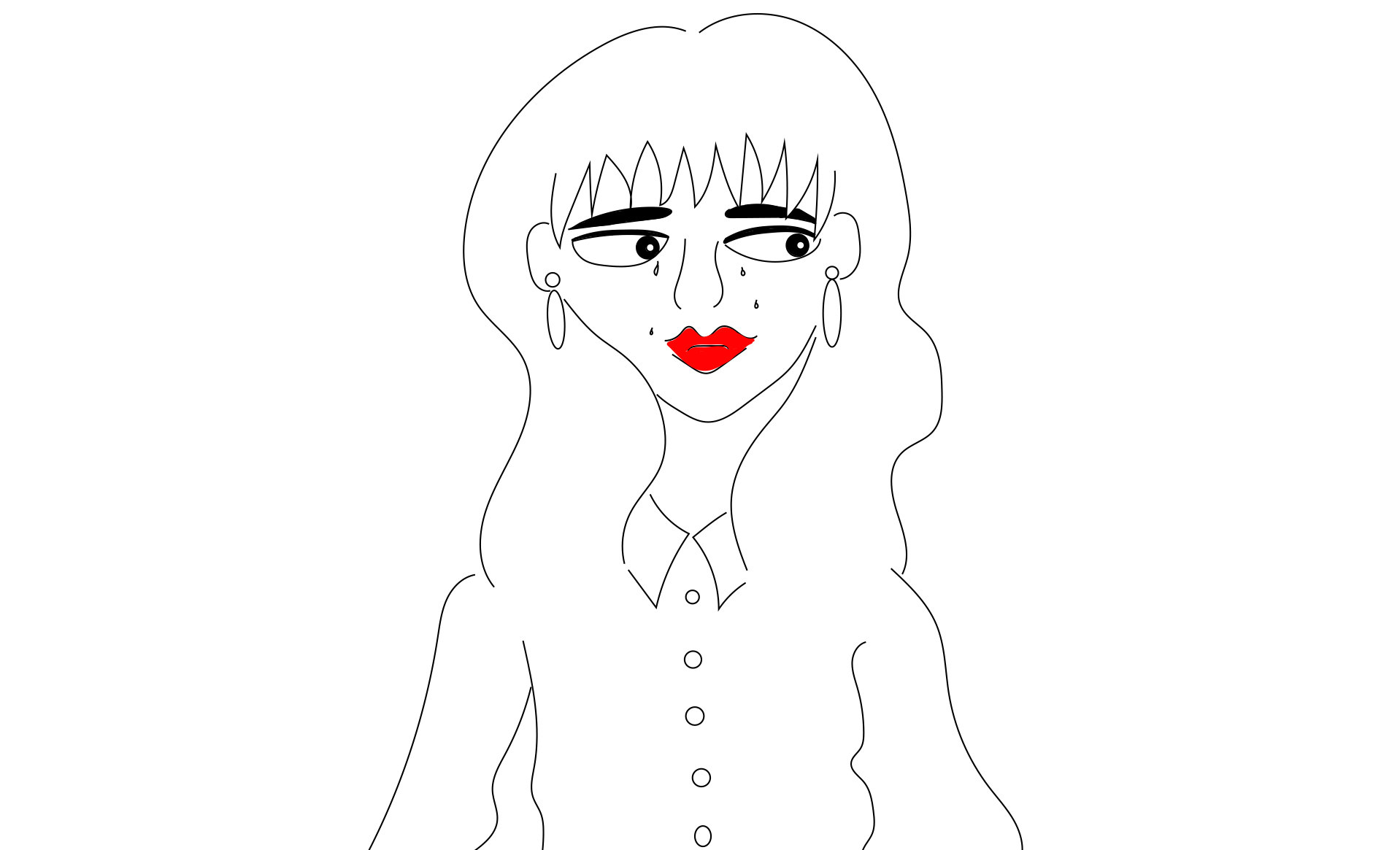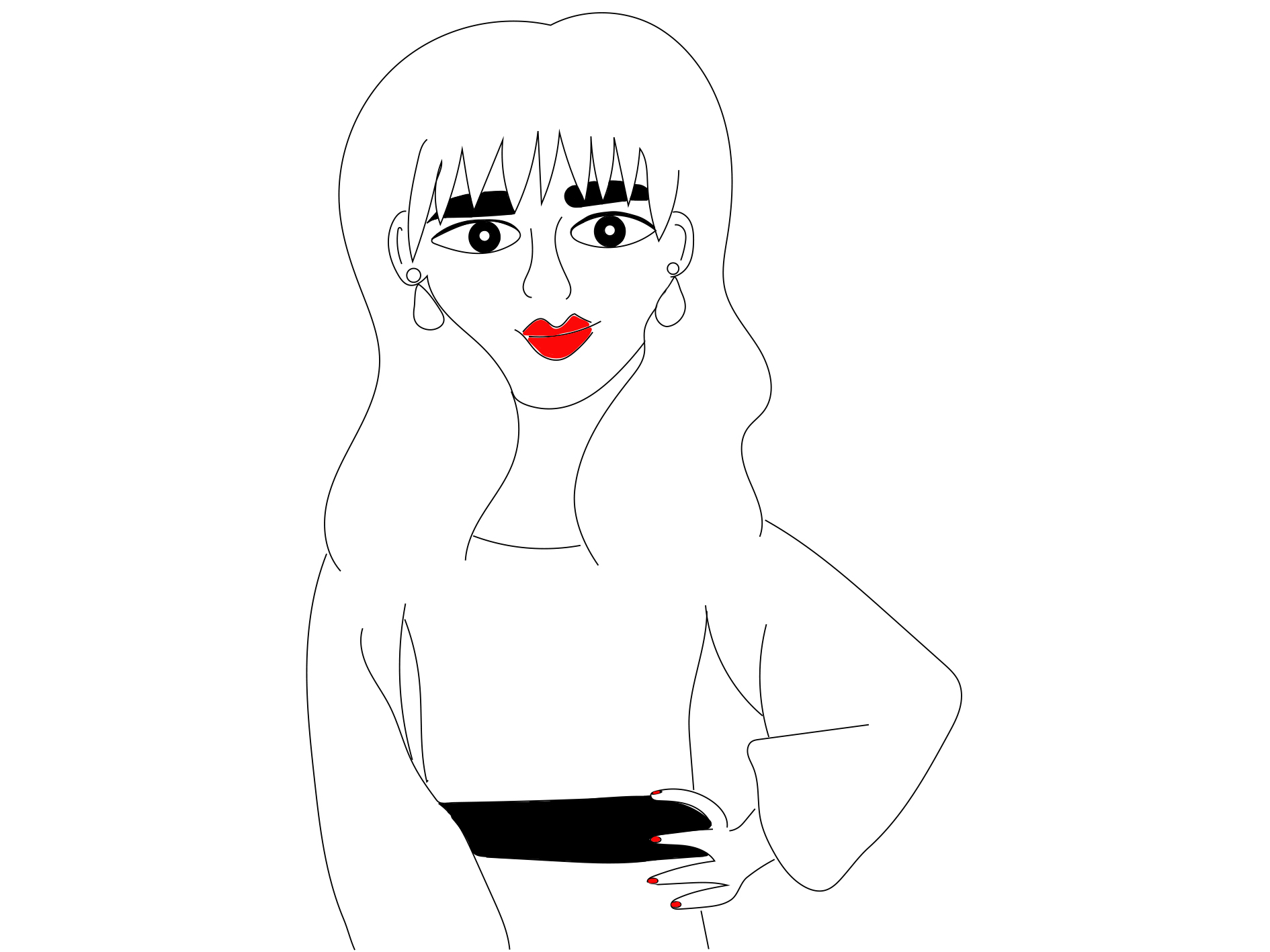ono davanti allo specchio.
Indosso un grembiulino nero con il colletto bianco, da cui scivola un nastro rosa abilmente infiocchettato dalla mamma: è così preciso da ricordarmi il papillon.
I miei occhi si riflettono nello specchio, ma smettono di concentrarsi sulla figura che ho appena descritto e finiscono dritti sulla cartella, che mi aspetta ai piedi del letto.
È bellissima, stampata e colorata. La chiusura è a scatto, le spalline sono imbottite: è il massimo del comfort, ma lei non basterà a farmi passare la paura del primo giorno di scuola.
Il mio sguardo si sposta sulle scarpe bianche e rosa: una via di fuga. Se proprio dovesse mettersi male, con queste posso sempre scappare. E con quel pensiero confortante, metto la cartella sulle spalle ed esco dalla mia stanza, mentre la mamma mi dice di scendere.
Salgo in macchina con lei, nel sedile che sta dietro il suo, e sento uno strano mal di pancia.
Mi sembra di riconoscerlo: è quello che mi viene per l’eccitazione la mattina di Natale, ma questo è più forte, più turbolento. Cerco di controllarlo, ma un attimo dopo, arriva un nodo in gola che quasi mi strozza.
Non posso mettermi a piangere, avevo promesso che non sarebbe successo.
Respiro, cercando di reprimere il senso di tristezza, paura, emozione e lì, seduta sul sedile dell’auto, mentre guardo fuori dal finestrino, mi concentro sull’unica cosa importante: la mia carriera.
Qualcuno crede che i bambini non abbiano le idee chiare in merito al proprio futuro, ma si sbagliano: io ho già deciso cosa farò da grande. I miei coetanei cambiano versione continuamente, immaginandosi prima dottori, poi astronauti, ballerini, cantanti, domatori di leoni, io invece, ho preso la mia decisione a quattro anni, e visto che ne ho appena compiuti sei, non credo ci siano più dubbi su quello che sarà il mio destino. Farò la stilista, disegnerò scarpe, come Ferragamo.
Tutti dovrebbero assecondare le proprie attitudini — questo me lo ha detto la nonna — e tutti dovrebbero coltivare i propri sogni, sin da piccoli, senza averne paura: non importa quanto grandi siano: anche queste sono parole della nonna.
Seppure involontariamente, credo che il suo modo creativo di indossare le cose, mi abbia trasmesso la sua passione per la moda. Le mie estati con lei si trasformano in un nuovo periodo scolastico, in cui studio inglese, giocando con le sue scarpe.
La nonna mi dà il permesso di guardarle, ma non di indossarle: ha paura che possa rompermi una caviglia, ma quando si allontana, riesco a sempre a metterne un paio: il mio preferito. Un sandalo alto e colorato che si chiama Rainbow, arcobaleno. Lo amo: con la sua zeppa è più facile mantenere l’equilibrio.
Più lo guardo, più mi convinco che solo chi possiede lo spirito di un bambino può disegnare un sandalo come questo.
Mi ha incuriosito. Ho chiesto alla nonna chi fosse il suo inventore e lei mi ha risposto: “Salvatore Ferragamo.”
Dietro a quelle due parole, pronunciate con fierezza e con un sorriso divertito, quasi meravigliato, c’era molto di più.
La sorpresa: se alla mia tenera età mi pongo domande del genere, c’è da chiedersi cosa succederà in futuro. Credo che sia stata questa considerazione a farle aggiungere il resto della storia.
“La disegnò per un attrice: Judy Garland. Lo chiamavano ‘Calzolaio delle stelle.”
E credo che sia stato il mio stupore interessato a produrre quello sguardo commosso, tipico di una nonna che realizza che la nipote è un portento.
Ho visto la scena del film che aveva in testa: Semola estrae la spada dalla roccia e diventa re di Camelot. E non ci vuole un genio per capire che da me si aspetti più o meno la stessa cosa: non posso deluderla. Se voglio diventare la regina delle scarpe, l’istruzione è indispensabile.
Il mio pensiero si conclude con l’unica constatazione capace di darmi il coraggio di scendere dall’auto, che si è appena fermata a pochi metri dalla scuola.
C’è una lunga fila di auto che ci precede, ma riesco a vederla in lontananza e di nuovo, vengo assalita da quello strano mal di pancia, da quel senso di inadeguatezza, mescolato ad ansia, paura, nausea.
La mamma abbassa il finestrino, quasi immaginasse che il mio stomaco sta facendo i capricci, ma se l’aria fresca che entra riesce a farmi sentire meglio, il rumore degli schiamazzi dei bambini mi riporta nel baratro.
Mi sporgo in avanti per vedere meglio, cercando di associare un’immagine alle loro grida: qualcuno piange, qualcuno ha già trovato un amico e lo tiene per mano, e io sono ancora chiusa qui dentro. È il mio primo giorno: non posso arrivare in ritardo.
Vorrei che un’elica spuntasse dal tetto dell’auto per superare l’ostacolo, ma mi rendo conto che alla guida non c’è l’ispettore Gadget, giusto mia madre, che sembra essere più emozionata più di me.
“Siamo quasi arrivate tesoro, come ti senti?” mi chiede.
Rifletto sulla sua domanda dettata dalle circostanze: so che conosce già la risposta e nonostante il suo istinto materno si sia sdoppiato e una parte di esso sia fortemente tentato dal proteggermi, l’altro fa i conti con il dovere di insegnarmi ad affrontare le difficoltà.
I miei tempi di risposta sono troppo lunghi, sono distratta da tutto, anche dal suo modo cauto di parcheggiare.
Scende dall’auto, recupera la cartella che mi aspetta nel portellone, poi, con un sorriso, apre la mia portiera e mi aiuta a scendere.
La vedo appoggiare il dorso della mano sotto i grandi occhiali da sole che ha sul naso e capisco che qualcosa non va.
“Stai piangendo mamma?”
“No… perché?”
Avrei voglia di sollevare le lenti che le coprono gli occhi, so di avere ragione, so che si è commossa.
“Sicura?” le chiedo di nuovo.
“Un pochino. Ma è solo per l’emozione. Questo è un momento memorabile anche per me.” conclude cercando di aggiustare la frequenza della voce.
Faccio un balzo, scendo e le prendo la mano che mi conduce verso la scuola, anche se ancora non ho capito chi stia accompagnando chi.
Cammino e continuo a guardarmi le scarpe, immaginando un’evasione in piena regola, ma poi è il senso del dovere che prende il sopravvento.
Penso alla nonna, al mio sogno, alle sue aspettative e mi faccio coraggio: studierò, sarò brava e quando avrò imparato tutto ciò che c’è da sapere, aprirò la mia casa di moda. Le donne faranno a gara per accaparrarsi le mie scarpe, le riviste mi pregheranno di concedere loro un’intervista e la nonna sarà la mia manager. E mentre immagino le celebrità del cinema che sfoggiano le mie creazioni, mentre vengono immortalate dai fotografi di tutto il mondo, arrivo davanti all’ingresso, fingendo che il lungo corridoio che mi aspetta sia un tappeto rosso: ora posso farcela.
Abbraccio la mamma, riprendo la cartella sulle spalle e le do un bacio. Poi, senza esitare, faccio il mio ingresso nel grande edificio.
Sulla destra c’è un grosso cartello su cui sta scritto ‘1A’: è lì che devo andare, raggiungo quella che dovrebbe essere la mia maestra e gli altri bambini che diventeranno i miei compagni. Li guardo, ma non reggo i loro sguardi curiosi, sono a disagio, ho sete e la pancia fa ancora quello strano brontolio, ma prima di essere colta da una nuova crisi di ansia, la classe si mette in marcia e io la seguo a testa bassa.
La maestra si ferma davanti a una stanza con la porta bianca, su cui sta affisso lo stesso cartello che poco fa ho visto in corridoio, la apre e ci fa cenno di entrare.
I miei coetanei corrono per prendere posto nella serie di banchi da due che ho di fronte: tutti sembrano aver deciso il proprio compagno, tranne me.
Avevo immaginato anche questo: uno degli effetti collaterali e calcolati che si valutano quando vai a vivere in una nuova città e i tuoi vecchi amici rimangono nel posto che hai lasciato. E forse, qualcuno deve aver pensato anche questo: c’è solo un banco rimasto vuoto ed è vicino a quello di un bambino dai riccioli castani.
Faccio un salto per rimettere in posizione la cartella sulle spalle e lo raggiungo per sedermi.
Gli schiamazzi continuano, il brusio di voci e risate crea un sottofondo musicale e ora che sono seduta, mi sento meglio.
La maestra si toglie gli occhiali da vista, li appoggia sulla scrivania e inizia a parlare:
“Buongiorno bambini, mi chiamo Maria Accardo e sarò la vostra insegnante.”
“Buongiorno signora maestra.”
La risposta all’unisono sembra uscita dal Piccolo Coro dell’Antoniano e mi fa sorridere.
“Qualcuno di voi conosce già il proprio compagno, qualcun altro, invece, farà amicizia con il tempo, ma desidero che impariate da subito ad aiutarvi tra di voi, non dimenticate che l’unione fa la forza.”
E dopo averci fatto presentare uno alla volta, ho scoperto che il mio compagno di banco si chiama Michele.
Il suono della campanella dell’intervallo mi fa uno strano effetto: mi fa sentire adulta.
La maestra ci conduce sul retro, in un cortile alberato, dove fare lo spuntino di metà mattina.
Il gruppo di bambini si è già diviso in due schieramenti ben distinti: le bambine si sono accaparrate la zona delle altalene, sotto la grande quercia, i bambini hanno già piantato la bandiera e colonizzato il campo da calcio.
Anche questa volta, resto indietro, tengo le distanze, quasi volessi pensarci bene prima di decidere da che parte stare, ma è evidente quale sia il mio posto. E mentre faccio per mettermi in marcia e raggiungere gli altri fiocchi rosa che mi assomigliano, sento qualcuno, dietro le mie spalle, che chiama il mio nome.
Mi giro sorpresa e sono ancora più sorpresa quando mi accorgo che è uno dei fiocchi azzurri che sta cercando di attirare la mia attenzione: è Michele.
“Ehi ciao. Pensavo che giocassi a pallone…” dico quasi per circostanza.
“No, non mi piace.” risponde desolato.
In effetti, a guardarlo bene, sembra molto posato e le sue scarpe: un paio di mocassini in camoscio blu, non sono adatte per prendere a calci una palla.
Se raggiungessi le altre bambine e gli chiedessi di seguirmi, forse si sentirebbe a disagio. E allora resto lì, con lui, sedendomi su una delle panchine di ferro dipinta di verde.
“Neanche a me piace il calcio.” dico sorridendo nel tentativo di rendermi complice.
“E cosa ti piace?”
Me lo sta chiedendo davvero? Posso davvero parlargli della mia carriera?
“Mi piace disegnare le scarpe, anzi, ad essere sincera è proprio la mia passione e quando sarò grande, sarà il mio lavoro.”
“Davvero?” mi chiede con un sorriso meravigliato.
“Sì certo. Sarò una stilista di scarpe.”
Il mio tono compiaciuto sembra contagiare il suo sorriso, che diventa ancora più grande, e i suoi occhi si accendono di entusiasmo.
“E come lo sai?” mi chiede curioso.
“Ho fatto esperienza con le scarpe della nonna e ho pure una figura di riferimento, si chiama Salvatore Ferragamo, lo conosci?”
Credo di aver esagerato, la sua espressione è traducibile in: ‘forse era meglio la partita di pallone.’
“No, ma mi piacciono le scarpe: mia madre ne ha tantissime.”
E di fronte a quella risposta, realizzo di essermi sbagliata: non lo sto annoiando, io gli interesso e gli interessa anche la mia passione. Lo conosco da un paio d’ore e sembra già il mio migliore amico.
“E tu? Sai già cosa farai da grande?”
“Certo. Sarò un fotografo di fama internazionale, come mio nonno, si chiama Ferdinando Scianna, lo conosci?”
“No, ma mi piacciono le foto, specie quelle di moda.” rispondo eccitata.
E mentre il suono della campanella interrompe i nostri discorsi impegnati riguardo al nostro futuro, penso che la stilista che diventerò avrà bisogno di un aiutante, di qualcuno che faccia le foto alle sue scarpe e lui mi sembra perfetto.
PUNTATA SPECIALE
Illustrazione: Valeria Terranova