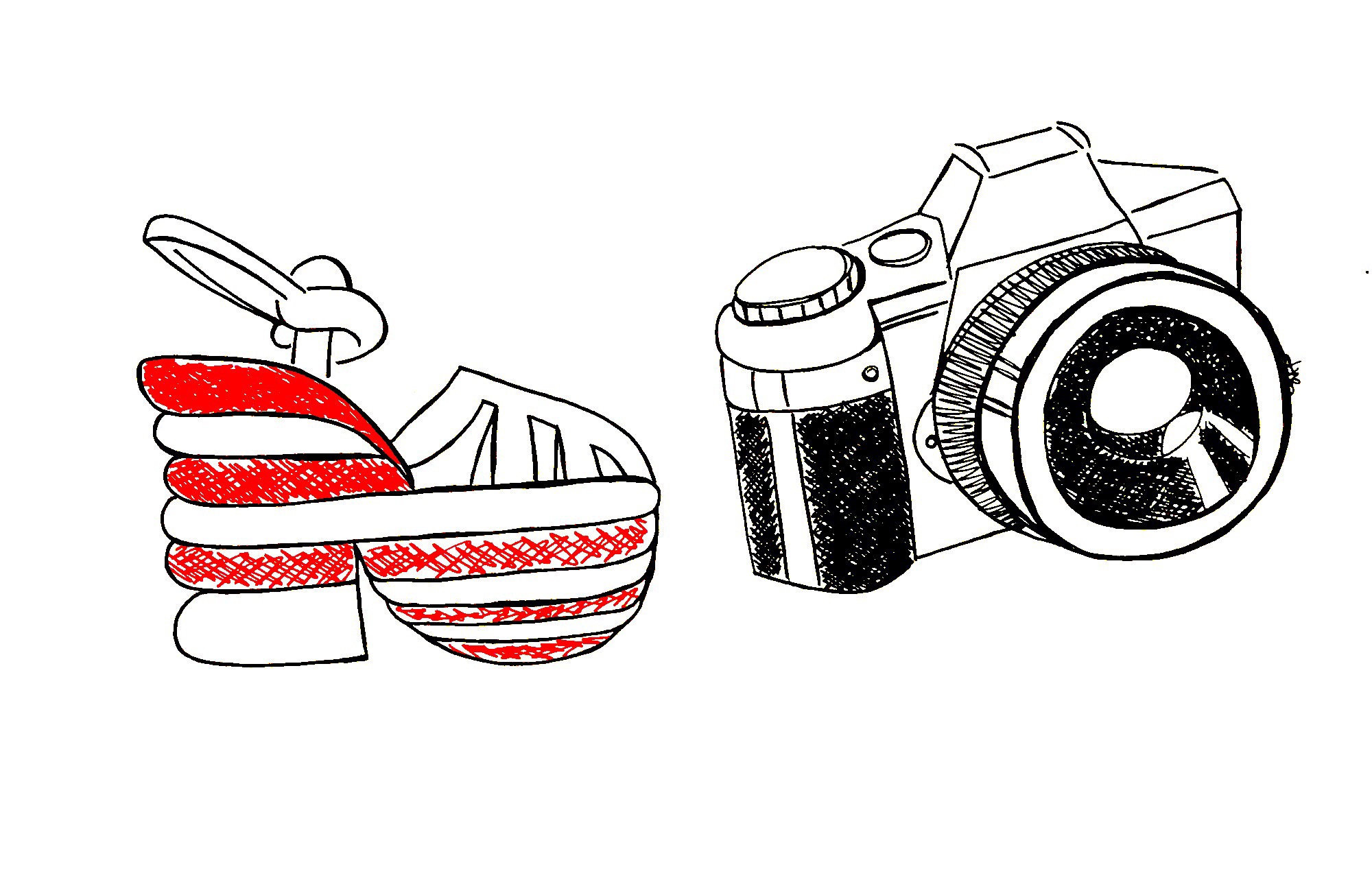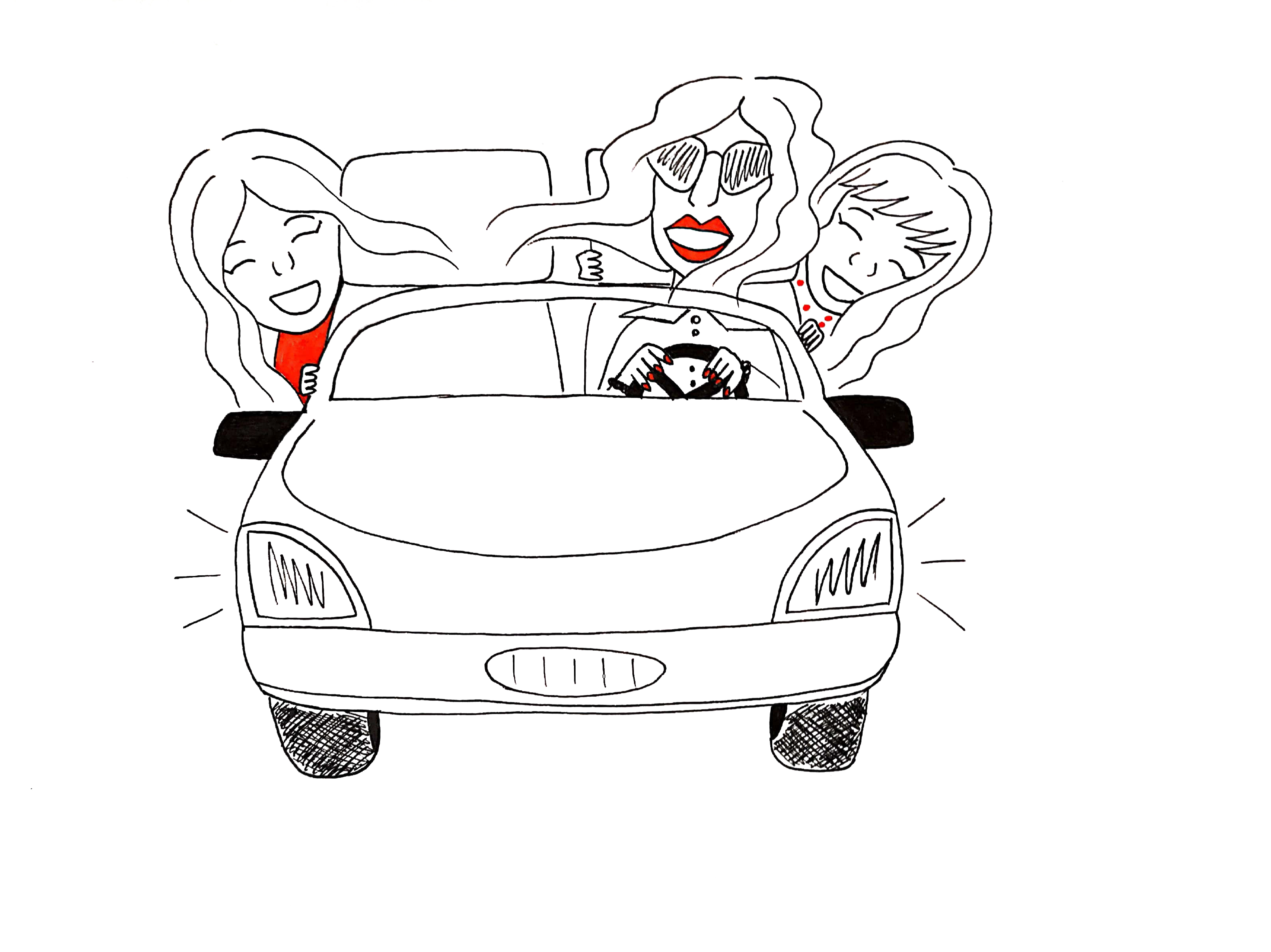l mio stomaco assomiglia a quello di un pesce rosso, né più, né meno: se non faccio attenzione a cosa mangio, lui si vendica, facendomela pagare con gli interessi. Succede, quindi, che domenica sera al ristorante, mangio una quinoa cucinata a mo’ di risotto e dopo il primo boccone, dico: “buonissima, forse è la cosa più buona che ho assaggiato dall’inizio della vacanza.”
La sacra famiglia lascia cadere la forchetta nel piatto, smette di mangiare e si volta verso di me per fare un appunto alla mia considerazione: “Mami è ovvio: mangi solo dei cuori di lattuga.”
In effetti non posso contraddirli: è vero che mangio sempre le stesse cose, ma stavolta il piatto è diverso. E sono fiera di essermi entusiasmata per tanta roba tutta insieme: quinoa, un litro e mezzo di panna, quattro etti di champignon, prezzemolo — che tutti detestano — e l’immancabile truffée. Cosa sarebbe Saint Tropez senza il truffée? Il truffée è il tartufo e in questa città, da qualche parte, deve esserci una miniera: lo mettono dappertutto. In qualsiasi ristorante tu vada, un terzo delle portate ha il truffée come ingrediente, lo infilano anche nell’impasto della baguette per farti abituare al suo sapore e da Senequier è pure nel cuore di lattuga. Finisco il mio piatto e inizio a sentirmi male: gonfiore, pesantezza e nausea mi tengono compagnia per un paio di giorni. Per qualche strana ragione, come sempre succede, l’organismo non solo non si dà pace per il malore, ma sente il bisogno disperato di ricercare le cause che lo hanno provocato, facendosi la solita vecchia domanda: cosa sarà stato? Arrivo alla conclusione che la quinoa cucinata a mo’ di risotto non è stata una buona idea, esonero dalle colpe il truffée e vado a farmi un regalo. Se qualcuno per sentirsi meglio, va dove lo porta il cuore, io vado da Pucci: dove ci sono le stampe colorate. Esco dopo dieci minuti con un completo composto da maglia e pantaloni: l’essenza della felicità. Decido di metterlo la sera stessa, aggiungo un paio di tacchi a stiletto, una piccola pochette e un orecchino pendente comprato con la Carola.
Ci incamminiamo verso la zona del porto per raggiungere il ristorante, e seppure in quella mise colorata, mi senta grandiosa, il senso di malessere provocato dal gonfiore non mi dà tregua. Emma si accorge delle mie smorfie, anche se tento di mascherarle con un sorriso, e mi suggerisce di usare la cura del nonno Beppe: dormire a pancia in giù.
È passato tanto tempo, ma il suo metodo per curare il mal di pancia è sempre lo stesso, e con me non ha mai funzionato. Distruggere l’immagine del ‘nonno medico in famiglia’ un po’ mi dispiace, rilancio quindi, dicendo che mi addormento in modo diverso:
“Io preferisco sdraiarmi sul lato sinistro.”
Pronuncio quella frase in modo quasi solenne, con la consapevolezza di conoscermi abbastanza, e la presunzione mi spinge addirittura più in là, facendomi aggiungere che la mia posizione preferita è quella del fenicottero. Ma quando pronunci la parola ‘fenicottero’ in presenza di una teenager che ti guarda divertita, devi anche mettere in conto di spararti la posa e mimarla. Ed è in quel momento, lungo la piccola via di Sephora, di Ravissante, di Ladurée che mi metto in mostra, portando il piede destro contro l’interno coscia sinistro, ma il tacco si infila nella stoffa dei pantaloni e perdo l’equilibrio. Per evitare la caduta, frantumo le unghie contro il muretto, ma resto in piedi. Fingo di ignorare il rumore dello strappo, convincendomi che sia solo la cucitura interna: non sono ancora pronta ad affrontare la realtà. La prima cosa che mi viene d’istinto è voltarmi per capire se qualcuno stia ridendo di me e della scena a cui ha appena assistito, ma ci sono solo Giaco e la Carola che non si sono accorti di nulla. Emma, invece, insospettita e preoccupata dal rumore sinistro emesso dai pantaloni nuovi e assassinati, mi suggerisce di farmi coraggio e di dare un’occhiata. E io l’assecondo, mi fermo e guardo. Mi sento mancare: due buchi, uno di entrata, uno di uscita, come quelli di uno sparo. Il primo ha un diametro di due centimetri, il secondo di quattro, ma ai miei occhi disperati sembrano venticinque.
“Li ho messi stasera per la prima volta.” dico mortificata.
“Mamma, dai, avevi detto che era un completo così comodo che lo avresti usato come pigiama…”
In effetti l’ho detto, ma intendevo tra qualche anno, doveva invecchiare insieme a me, farsi cinque o sei uscite ufficiali… Sì insomma, aveva tutta la vita davanti e invece, guarda cosa ho combinato. E dopo aver messo sul piatto il solo aspetto positivo, Emma lascia andare la risata che la vicenda ha inevitabilmente suscitato, e io la imito, mentre mi spiaccico una mano in faccia, quasi a voler dire: “#SemoConsumatiDallaJella, tutte a me.’
Senequier è a pochi metri dal luogo dell’incidente. Faccio il mio ingresso a gambe strette, vorrei sentirmi grandiosa come a inizio serata, ma il buco è troppo visibile, le persone sedute a tavola se ne accorgeranno e avvicinandosi all’orecchio di chi gli sta vicino, sussurreranno: “anvedi questa che se sente sto****o e c’ha pure i pantaloni bucati.”
Sto morendo di vergogna. Stringo le gambe ancora di più, mancano un paio di passi e poi sarò seduta al tavolo. Giaco mi aiuta spostando la sedia pesante dipinta di rosso, mi lascia sedere e si mette vicino a me.
“Ti sei fatta male?” mi chiede subito dopo essersi seduto.
“Io no, loro sì.” dico mentre abbasso la testa verso i buchi, cercando di mostrarglieli con disinvoltura. Ma mentre una delle sue mani è tra le mie cosce per capire quanto grandi siano, il cameriere arriva al nostro tavolo. Il suo sguardo è tra lo sconvolto e lo schifato e io mi sento morire. Vorrei spiegargli che siamo vittime degli eventi, ma prima che possa aprire bocca, ci porge i menu in modo severo. Le bimbe, ignare che il cameriere ci ha appena scambiato per due depravati, aprono la carte e decidono cosa mangiare. Io vorrei mangiarmi il tacco delle scarpe. Ma come mi è venuto in mente di fare una cosa tanto stupida? La domanda mi perseguita per l’intera cena. Sono davvero dispiaciuta. A salvarmi è la Tarte Tropezienne, che ci viene servita su un piatto bianco con la scritta rossa, in dose massiccia — da dividere per quattro. Il suo aspetto da ‘bella senz’anima’ mi fa dimenticare i tacchi dannati che hanno rovinato per sempre i miei pantaloni da sballo. Sono così euforica che non mi arrabbio nemmeno quando mi scivola un pezzetto dal cucchiaio e finisce su una delle mie gambe. Più che Saturno, io ho l’intero sistema solare contro, ma preferisco mettermi a ridere. E proprio mentre sto ciucciando il dito che ha raccolto la crema chantilly dai pantaloni, chi entra? Karl Lagerfeld. Non è una novità: Sua Maestà viene sempre qui, tutte le sere alla stessa ora, il suo tavolo è sempre lo stesso, ma questa volta siamo noi ad averne occupato uno diverso ed è proprio quello che sta vicino al suo.
Si avvicina e si siede insieme a una delle icone maschili di Chanel: Brad Kroenig, ai suoi due bambini, Jameson e Hudson — modello anche lui — alla moglie Nicole e alla versione francese di Ivan Drago, la sua guardia del corpo. I suoi modi, decisamente sprezzanti, mi fanno venire voglia di tirargli un pezzo di torta usando il cucchiaio come catapulta, ma Karl è più importante: è a un metro da me e ho pure i pantaloni bucati, meglio agire con discrezione.
Faccio dondolare la sedia per osservarlo meglio, è quasi mezzanotte e lo vedo togliersi gli occhiali scuri con cui di solito si mostra in pubblico, per abbandonarli sul tavolo — vicino alla bottiglietta di Perrier che gli è già stata servita con ghiaccio e limone — lasciandomi il piacere di soddisfare quella domanda a cui tutti, almeno una volta nella vita, hanno cercato di rispondere: come sarà senza? Diverso: un cucciolo di panda. Gli occhi sono grandi, attenti. Divertiti con i bambini che sono seduti con lui, infastiditi con gli ammiratori che tentano l’avvicinamento con carta e penna, sperando nell’autografo che mai concede. Lo guardo con la grande ammirazione di sempre, quella che di solito si innesca quando mi trovo di fronte a personaggi di tale calibro, ma questa volta si aggiunge una componente emotiva: la tenerezza. Vederlo nella veste di nonno, mentre tiene in braccio il più piccolo dei bambini, che assaggia il gelato facendone cadere un po’ sui suoi pantaloni, mi fa capire che non importa se di cognome fai Alessi o Lagerfeld, quando una delle cose che indossi è destinata a fare una brutta fine, non c’è niente da fare.
Illustrazione: Valeria Terranova