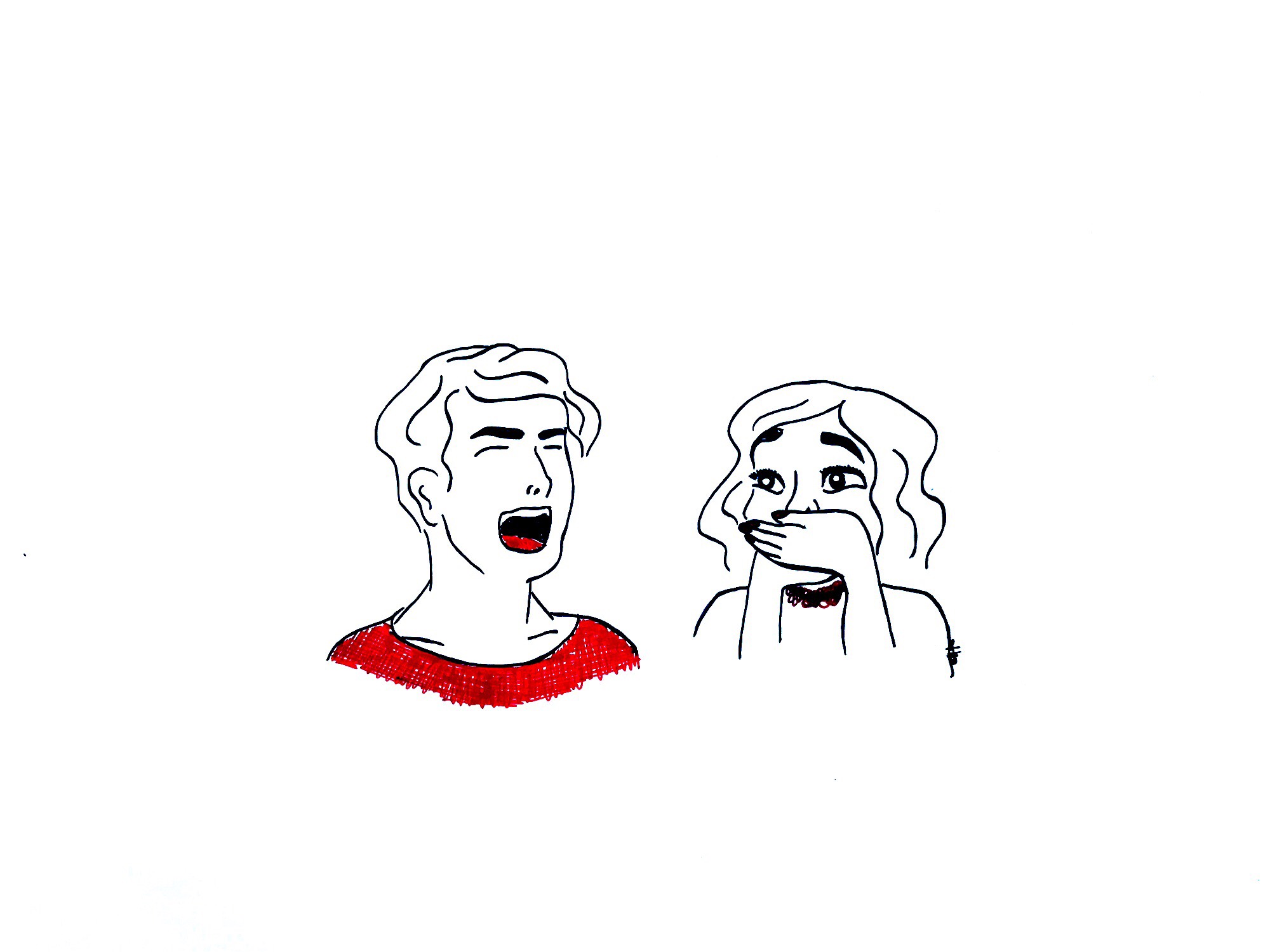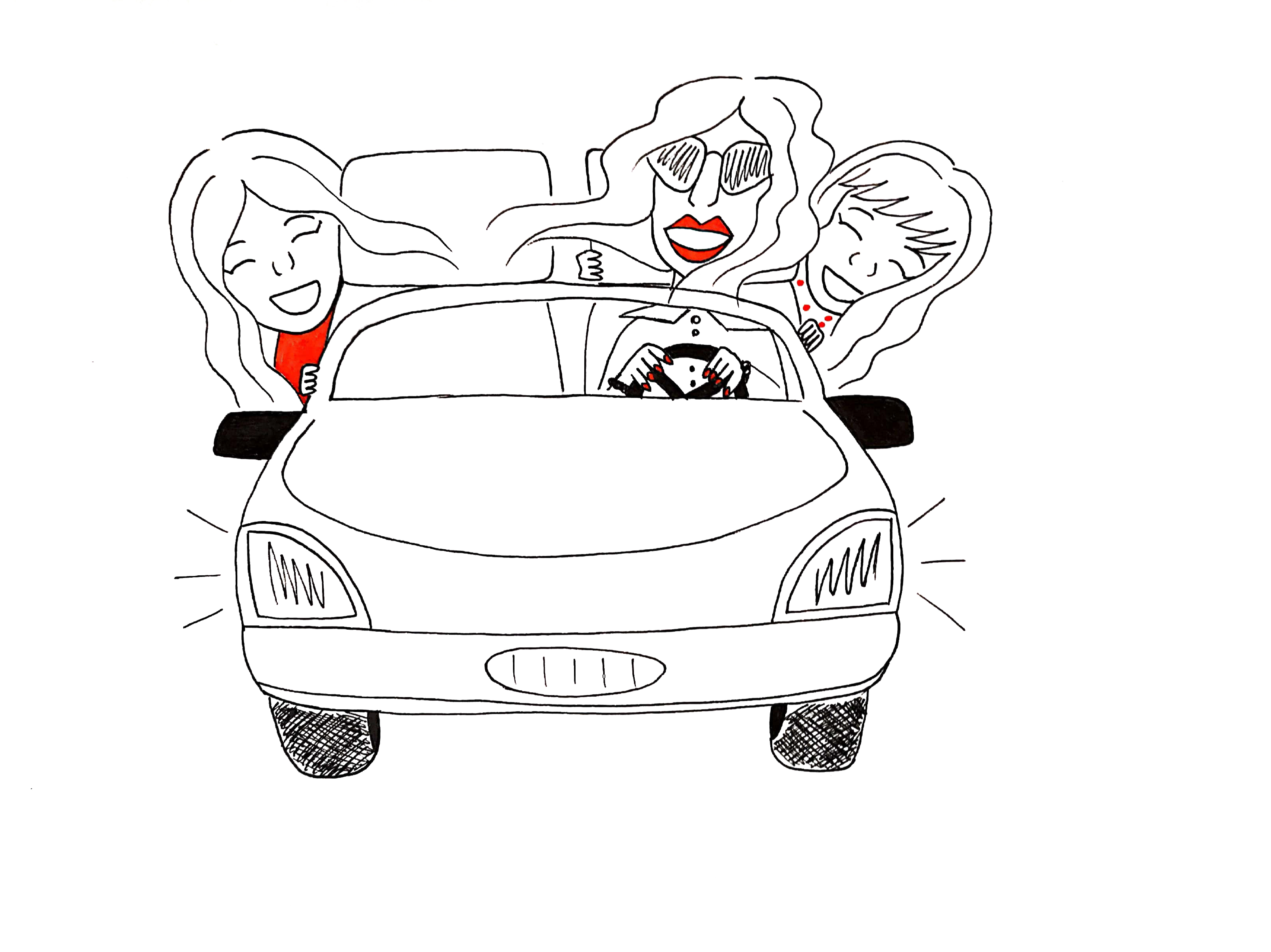ichi ha deciso di invitarmi fuori a pranzo.
Vuole tutti i dettagli del ‘passato torbido’ che gli ho tenuto nascosto: così ha definito il mio pezzetto d’infanzia in Versilia. Ma anche scavando, non credo che troverà niente di scabroso: Paolo è stato ‘il mio primo bacio, era solo una storia tra bambini.
Eppure, anche se è passato tanto tempo, non ho dimenticato niente di quelle estati felici con la nonna.
In Versilia, le spiagge sono grandi, la sabbia è fine, soffice e con lei era facile costruire i castelli. La nonna mi guardava dalla tenda che stava vicino alla riva, il vento le muoveva i capelli bruni, scoprendole il viso abbronzato, e gli occhiali extra large filtravano il suo sguardo: quello di chi ti tiene d’occhio, anche da lontano. La guardavo dal bagnasciuga, mentre pescavo l’acqua con il secchiello, e mi sembrava un agente segreto sotto copertura, con il costume intero a fantasia. Una favolosa mise d’ordinanza che la rappresentava divinamente.
Se chiudo gli occhi, mi sembra ancora di sentire il suo profumo: gelsomino, rosa, miele. Curioso, come la sua bottiglia, che teneva sulla specchiera, vicino ai trucchi, da cui non potevo stare lontana.
Un busto femminile ricoperto da piccole foglie dorate e fiori colorati, che poggiava su un piedistallo rosa, come il suo nome: Shocking, Shocking di Schiaparelli.
Andare al mare con la nonna, significava crescere e guadagnarsi, anno dopo anno, le mie briciole di libertà: piccole, ma grandi conquiste.
Decidere da sola quanto Nesquik mettere nel latte, fare il bagno in anticipo rispetto all’ora stabilita. Essere obbediente per meritare una nuova Barbie — ignorando che sarebbe stato meglio concentrarsi sui Lego — o fare in modo che cambiasse idea sulla frutta a merenda, e convincerla che un ricoperto al cioccolato mi avrebbe reso più felice.
Le direttive della mamma erano chiare, ma le regole potevano essere infrante e trasformarsi in piccoli segreti che sarebbero rimasti solo tra noi.
Il Bocconcino Dai Dai fu uno di quelli, e se non ci fosse stato, ieri sera, non avrei riconosciuto Paolo.
Le richieste cambiarono, negli ultimi anni, assomigliavano a quelle di una bambina che giocava a fare la ragazzina. Volevo allontanarmi dalla tenda e dal suo controllo visivo, per rimanere al tavolo da ping pong tutto il pomeriggio, dove il bambino più bello della spiaggia dava il meglio, per fare colpo su di me.
Anche io facevo lo stesso: volevo i capelli ondulati, da sfoggiare con i bikini colorati e con gli abiti bianchi da principessa. E quando ci ripenso, è come se la nonna fosse ancora qui: a farmi le trecce da sciogliere l’indomani.
Michi mi ha detto che ieri notte, le ultime parole che ho pronunciato — prima di cadere in un coma profondo — sono state: ‘‘Dio benedica il Bocconcino Dai Dai.” Ma si dicono sempre cose insensate, dopo aver bevuto due Vodka Tonic a stomaco vuoto. Sono solo parole, è solo ‘il mio primo bacio’ e non so niente di lui.
Michi non dovrebbe farsi strane idee e poi sono una mamma, dovrebbe saperlo che gli uomini fuggono dalle donne con figli.
Stamattina ho chiamato Clara. Secondo il programma che avevo preparato per gestire Sofia, durante la mia assenza, doveva essere con lei.
Ho detto loro la verità: volevo che sapessero dove mi trovo realmente. Quanto a Davide: credo che scoprirà oggi che non sono a Miami: quando comprerò l’albero di Natale all’asta di beneficenza — con la nostra carta di credito — e la banca lo chiamerà per avvisarlo dell’uscita ‘importante’. Ma sarà troppo tardi: la transazione sarà già eseguita.
Tac. Un delizioso abete a forma di abito da sera, messo all’asta da Moschino.
Starà benissimo nel negozio della signora Kraler.
Sofia sta bene e non vede l’ora di incontrare il suo chihuahua. Non ha fatto domande sulla lunghezza del pelo e nemmeno sul suo colore, e non voglio pensare a come reagirà, quando si troverà di fronte all’esatto contrario di ciò che si aspetta. Ora servirebbe solo a rovinare il pranzo dedicato al mio ‘passato torbido’ e io non posso perdermelo.
A interrompere i miei pensieri è proprio Michi, che, in tono annoiato, mi ricorda che è ora di pranzo.
“Eva sta morendo di fame…”
“Eccomi…” dico mentre finisco di prepararmi allo specchio.
Dopo quattro minuti, sono di fronte a lui con il mio paio di J Brand a zampa, abbinato al maglione con inserti in check di Burberry, all’eco pelliccia multicolor di Marni, alla Trapeze bicolore di Celine e allo Scarponcino di Timberland.
“Che ne pensi?” chiedo soddisfatta.
“Grintosa, mi piace. Anche se non credo che tu abbia messo insieme tutto questo, pensando al nostro pranzo…”
Riconosco quel tono provocatorio: sta insinuando che la mia mise non è stata concepita in suo onore e odio ammettere che un po’ ha ragione. Quelle cinquanta sfumature di grigio brizzolato saranno presenti all’asta di oggi e ho bisogno di sentirmi irresistibile.
“Non sarai geloso?”
“Certo.”
“Davvero?” chiedo compiaciuta.
“Certo: di lui.” conclude strizzandomi l’occhio.
Apre la porta della stanza e mi cede il passo per uscire.
Scendiamo le scale e raggiungiamo la hall, dove chiediamo al concierge di chiamarci un taxi.
Michi ha prenotato in un ristorante a pochi minuti dal centro, guardo fuori dal finestrino dell’auto, cercando di farmi distrarre dal panorama, ma non ci riesco, la mia mente torna da lui. Ripensa al suo sorriso, ai suoi occhi vispi che il tempo ha lasciato intatti e un piccolo brivido corre giù: lungo le braccia, fino ad arrivare alla bocca dello stomaco, che mi sembra quasi di sentire vibrare.
“A cosa stai pensando?”
Mi volto verso Michi che sta seduto vicino a me e lo vedo perlustrare il mio sguardo con il suo. A volte, è come se avesse il potere di leggermi nel pensiero.
Potrei essere sincera, ma poi comincerebbe con le sue domande imbarazzanti e io mi sentirei a disagio.
Mi sono sempre chiesta come si fa a parlare di qualsiasi cosa davanti a uno sconosciuto, come succede nei film.
E prima che possa inventarmi qualcosa di distante dalla realtà, il taxi si ferma.
Scendiamo dall’auto e ci troviamo di fronte a una bellissima baita di montagna con gli scuri verdi, alle cui spalle si intravedono le seggiovie.
Michele sale le scale e io lo seguo, curiosa di vedere come possa essere dentro.
L’atmosfera è calda, accogliente, il legno è ovunque: sul tetto, alle pareti, anche sul pavimento e le sedie intagliate mi ricordano quelle degli elfi delle favole.
I tavoli sono apparecchiati con cura e il profumo, che proviene dalla cucina, mi fa venire l’acquolina in bocca.
Una signora robusta e gioviale ci accoglie con un sorriso e ci accompagna al nostro tavolo: un delizioso angolo per due, vicino a una piccola finestra che dà su uno splendido panorama innevato.
Mi siedo e sono felice di essere qui: sola con lui.
Metto il tovagliolo sulle gambe, i polsi sul tavolo, pregustando un antipasto fatto di chiacchiere, ma ad attirare la mia attenzione è una famiglia numerosa, che è appena entrata: mamma, papà e quattro bambini con scarponi, nasi arrossati e giacche pesanti.
La stessa signora che ci ha appena fatto accomodare, li saluta e li abbraccia con affetto: sembrano di casa e sembra anche che il tavolo a loro assegnato sia proprio quello accanto al nostro, al centro della sala.
La famigliola felice ha appena sciolto nell’acido il mio ‘sono felice di essere qui: sola con lui’.
Li osservo curiosa, non tanto per la situazione che dovrebbe smuovere la mia malinconia, ma per la curiosa disposizione di ogni singolo elemento della formazione. I genitori, seduti uno di fronte all’altro, cercano di fare conversazione, nonostante le grida e gli schiamazzi dei figli. Schivano abilmente i tranci di pane che vengono lanciati da una parte all’altra del tavolo, e trascurano le loro insistenti richieste:
“Ho fame.”
“Ho sete.”
“Devo fare la pipì.”
Continuo a ripetermi che non sono figli miei, che non è un mio problema, che la colpa è solo dei genitori. E il pensiero che Andrea possa insegnare l’educazione a Sofia, mi fa passare l’appetito.
“Hai fame?” mi chiede Michi ad alta voce, tentando di superare la soglia del volume che tiene il tavolo dei vicini.
Anche lui è infastidito. Anche lui si sforza di ignorare il loro comportamento irritante, e so bene che non è facile: ama i bambini, ma non sopporta quelli maleducati. Come me del resto.
Un cameriere con una giacca tirolese — è evidente che a Cortina è di casa — si avvicina al nostro tavolo, a occhi chiusi: forse per evitare di essere colpito dai lanciatori di pane.
Ci lascia i menù, guardandosi le spalle.
Osservo le sue movenze petulanti e mi sembra intimorito.
“Posso consigliarvi i piatti del giorno?”
Dal tono della sua voce si intuisce che ha paura di andarsene. Ho come l’impressione che ci stia chiedendo di ordinare subito, per fare un giro soltanto da qui alla cucina.
“Abbiamo un arrostino di diaframma di manzo del Nebraska con purea di patate. E un’insalatina di finocchi, arance e noci.
“Perfetto.” dico chiudendo il menù. “Il manzo per lui, l’insalata per me.”
“Ma io volevo provare il cervo…” mi interrompe Michi.
“Sei un mostro! Vuoi davvero mangiare Bambi?”
I miei occhi languidi saprebbero intenerire anche il cacciatore di Biancaneve , figuriamoci Michele.
“Okay. Venduti.” conferma rassegnato.
Il cameriere raccoglie i menù, ci ringrazia una decina di volte e si rimette in marcia con l’ordinazione, coprendosi il volto con l’avambraccio, per scansare gli attacchi.
Guardo fuori dalla finestra, faccio un sospiro e guardo Michi negli occhi.
Sorrido di questa situazione drammaticamente comica e l’espressione del mio amico sembra aver colto lo spirito con cui gli suggerisco di affrontare il cambio di programma che la famiglia rumorosa ci ha imposto.
Facciamo spallucce e iniziamo a parlare, fingendo di essere soli.
“Che effetto ti ha fatto rivederlo?” mi chiede, mentre si appropria di un pezzetto di pane da sgranocchiare.
“Mi ha ricordato una parentesi deliziosa della mia infanzia, e anche se ha perso il suo caschetto castano, è stato bello rivederlo.”
“Solo questo?”
Michi continua a esplorare le mie emozioni, ma non riesco a capire dove voglia arrivare.
“Punto primo: potrebbe non essere single, magari è fidanzato, sposato…”
“Magari è gay…”
“Esatto, in quel caso, sarei fuori dai guai…”
“Guai? Quali guai?”
Come ci riesce? Ogni volta che cerco di essere riservata per tenere a freno la sua curiosità, riesce sempre a fregarmi: a farmi dire cose che non vorrei.
“E punto secondo”, continuo come se nulla fosse, “ho una figlia: sono un pessimo partito.”
“Solo se hai dei figli come questi.” precisa, facendo un cenno con il capo verso il tavolo vicino.
Anche questo è vero, ma dopo dieci minuti, la situazione è decisamente più tollerabile: i bambini hanno smesso di gridare, di fare la guerra con il pane e la mamma si è alzata da tavola per accompagnare il più piccolo in bagno. Anche il volume delle loro voci si è abbassato, riesco quasi a sentire la mia pancia che brontola e il cameriere, in arrivo con i nostri piatti, mi fa pensare che l’incubo sia finito.
Lo vedo allontanarsi, mamma e bambino si risiedono e iniziamo a mangiare.
“È stato un bacio alla francese?”
“Michi… parla piano.” lo rimprovero, abbassando la voce.
“Non possono sentirci, rispondi…”
Deglutisco, aspetto che il rossore svanisca, do un colpo di tosse e cerco di soddisfare la sua curiosità, buttandomi sul sentimentale.
“No. Assolutamente…”
“Il tuo primo bacio non è stato un bacio alla francese?” mi interrompe.
“No.” rispondo secca.
“Allora non vale.”
“Certo che vale.”
“No che non vale: un limone è un limone.”
Lo guardo con la bocca spalancata, i bambini, seppure detestabili, non meritano di assistere a una conversazione a luci rosse.
“Possono sentirci.” lo ammonisco di nuovo.
“Ho detto limone, non ho detto bacio con la lingua.”
Ora l’ha detto.
Prendo un pezzo di pane dal cestino e lo infilo in bocca, cercando di frenare l’imbarazzo, ma la domanda che arriva, un attimo dopo, mi fa quasi strozzare.
“Non ci ha nemmeno provato? Dico a infilarne un pochino?”
Lo fulmino con lo sguardo, mentre cerco il coraggio di voltarmi verso la famiglia rumorosa di poco fa, che si è appena dissolta nel nulla, per fare spazio a quella silenziosa, attenta e molto interessata ai nostri discorsi.
“Michi! Smettila.”
Ma dai suoi occhi, è palese che questa situazione lo diverta. Ruba una foglia di insalata dal mio piatto, la mette in bocca e torna all’attacco:
“Neanche una sculacciata?”
Non riesco a rispondere, mi sta facendo fare la figura della pervertita: avevo solo undici anni, santo cielo!
Abbasso la testa, cercando di nasconderla dentro l’insalata per la vergogna. Lui trattiene una risata, apre la bocca e sono già in ansia per ciò che sta per dire: “Okay, bastava dirlo che non ti ha mai sculacciata.”
La famigliola si è completamente ammutolita. Sono tutti a bocca aperta e ci guardano: voglio morire.
Mi giro di scatto verso Michi con un espressione traducibile in: ‘hai visto cosa hai combinato?’ ma neanche questo riesce a fermarlo:
“Pinze per capezzoli?”
Qualcuno mi dica che non l’ha detto davvero.
La mamma mi guarda indignata.
Ma come? Fino a poco fa, ero io quella indignata, e adesso? I ruoli si sono scambiati.
Sento i suoi occhi severi su di me, la sua forchetta cadere nel piatto con disprezzo e la sua voce irritata: “bambini: è ora di andare.”
Si alza da tavola e tutti la seguono, senza voltarsi.
“Ora sarai contento?” chiedo arrabbiata.
Annuisce con la testa e lascia andare la risata che ha tenuto a freno fino a ora.
La riconoscerei tra mille: rumorosa, sguaiata e altamente contagiosa.
Anche io mi metto a ridere di gusto, liberandomi dal contegno che ho cercato di mantenere, e penso che sia la degna conclusione di questo pranzo.
“Conto e caffè?” mi chiede, guardando l’orologio.
“E un taxi: è ora di andare.”
DICIASSETTESIMO EPISODIO
Illustrazione: Valeria Terranova