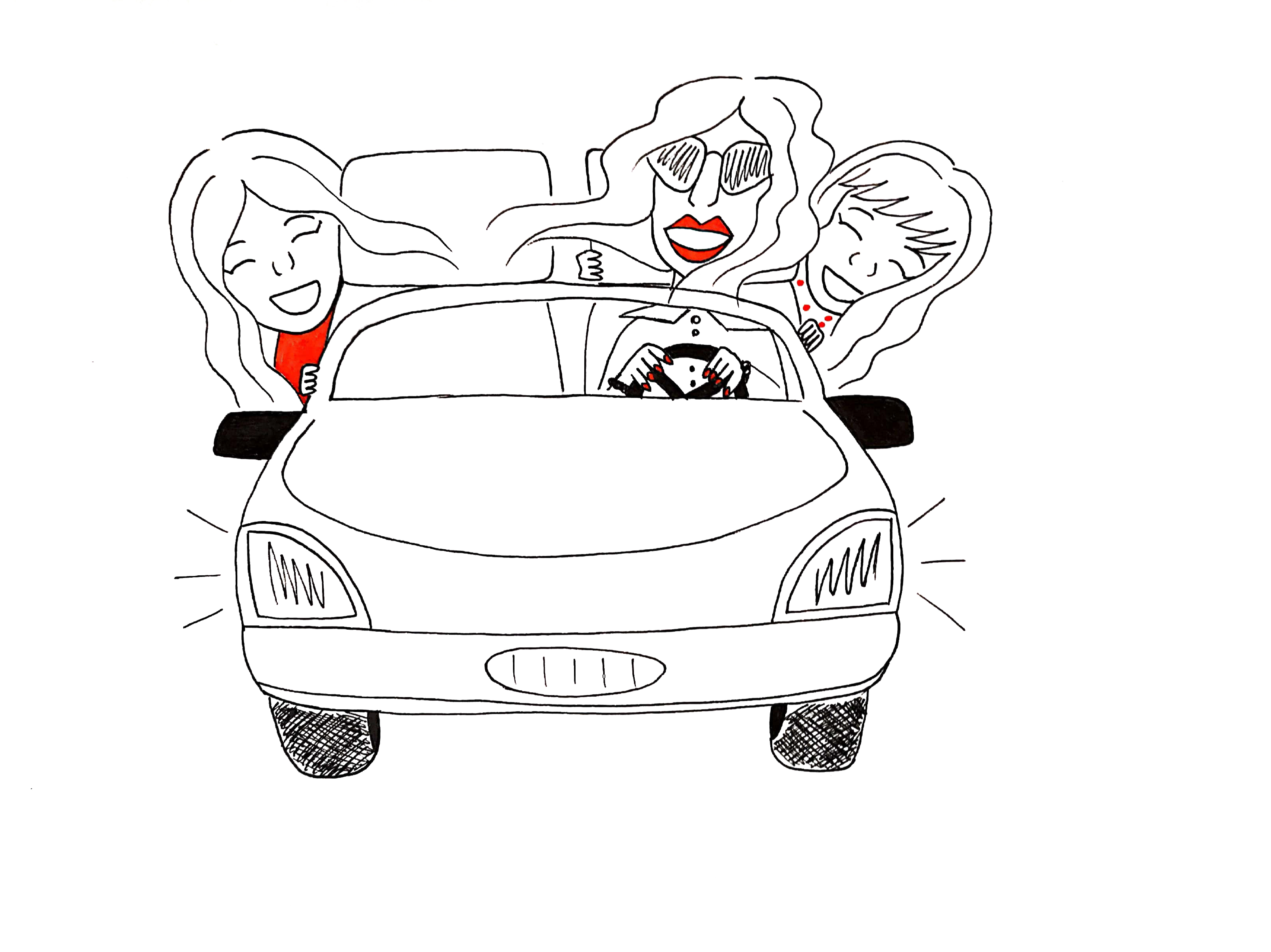eroplano che te ne vai, lontano da qui chissà cosa vedrai…”canticchia Claudia. “Capito? Quando hai paura che l’aereo stia per cadere, canta che ti passa!”
“Okay, okay, smettila di dire quella parola”, ribatto io.
“Quale?”
“Come quale? Cadere…”
“Preferisci precipitare?”
Questa non ha capito: io ho il terrore di volare e lei non dovrebbe dire certe cose in mia presenza. Eppure mi convinco a partire, a prendermi una piccola vacanza oltre oceano con Giaco — le bimbe restano dai nonni — ma prima faccio le valigie.
Qualcuno dalla regia mi fa sapere che laggiù fa molto freddo e, malgrado lo patisca molto, di solito me ne frego.
Sono abituata a non coprirmi troppo per non sembrare l’omino della Michelin. E quando Fay si offre di mandarmi una serie di total look da sfoggiare a New York, anche se i pezzi che ho scelto non hanno volutamente tenuto conto dei dieci gradi sotto lo zero, aggiungo un paio di piumini miei e chiudo la valigia. Non si sa mai.
Io e Giaco, che in viaggio siamo un po’ l’equivalente di Bianca e Bernie — dove io sono Bernie e lui è Bianca — entriamo in aeroporto.
Abbiamo due posti in business, questo dovrebbe agevolarmi: gli spazi sono molto più comodi, puoi mangiare e soprattutto bere finché vuoi, puoi sbronzarti, perdere i sensi — dicono che questo sia il rimedio migliore — ma stiamo per imbarcarci e ho già mal di testa.
“Tutto bene, amore?” mi chiede Giaco.
“Sì, sì…”
Ho la stessa faccia di chi sta salendo su un patibolo per essere impiccato, ma lui non la nota: sta mostrando i biglietti alla hostess sorridendo.
Cosa ride?
Ho appena messo piede sull’aereo e sto per piangere… anzi piango.
Giaco mi abbraccia. Credo che avesse preventivato una mia crisi, forse anche più di una, ma probabilmente sperava che la prima si presentasse in fase di decollo.
Ma questo è un volo più lungo, le probabilità di morire sono più alte, o almeno è quello di cui sono convinta, e quindi ci sta.
“Signora, non faccia così”, mi consola la hostess alta, bionda e bella.
Non so se a irritarmi di più sia il suo chignon perfetto abbinato al rossetto impeccabile, o il semplice fatto che mi abbia chiamato signora a quel modo facendomi sembrare una vecchia piagnucolona.
Lei, che avrà appena vent’anni e nessun figlio a carico, cosa può saperne di cosa prova una madre in un momento come questo?
E lì, mentre mi chiedo se sia piuttosto merito del botox se ha un viso di porcellana, lei riapre bocca: “Vi accompagno ai vostri posti, prego…”
Giaco mi prende per mano e la segue, io trascino di mala voglia il trolley dietro di me.
A un tratto in mezzo al corridoio, alla vista dell’involucro che racchiude le mascherine dell’ossigeno che potrebbero penzolare, delle cinture di sicurezza in cui resto sempre impigliata e dei sacchetti marroncini per il vomito, mi fermo atterrita.
C’è qualche passeggero già seduto che si sta facendo il segno della croce, e ad aumentare il mio avanzato stato d’ansia è il rumore dei motori di questa supposta volante.
Sto tremando.
“Enri, tutto okay?” mi chiede Giaco preoccupato.
“No, non è tutto okay”, bisbiglio per non farmi sentire dalla hostess. “Stiamo andando a farci i c***i nostri dall’altra parte del mondo, e se questo coso dovesse cadere, come faranno le bimbe senza di noi?”
Con nonchalance impercettibile lui si tocca i genitali.
A convincermi che in quanto madre è giunto il momento di comportarmi da adulta è la hostess che sta venendo nella mia direzione con la sua faccia da saputella.
“Tutto bene?” mi chiede lei con un sorrisetto di plastica.
“Sì certo”, rispondo rimettendomi in marcia.
Arriviamo ai nostri posti, Giaco mi offre quello vicino al finestrino.
Il sorriso torna sul mio viso quando la stessa hostess, che poco fa ho definito una carogna, mi offre un beauty case di Bulgari con tutto il necessario per l’igiene personale, anche a Giaco ne viene data una di colore diverso, ma lui non ci fa caso: è già al secondo bicchiere di champagne.
Capisco dal suo alito fruttato che sta adottando la tecnica dello stordimento per mostrarsi meno fifone di quanto non sia, ma quando l’aereo inizia a muoversi sulla pista e prende velocità, cerco il suo conforto stritolandogli la mano.
“Se vuoi dirmi un’ultima volta che mi ami, questo è il momento”, mormoro caricando i miei occhi di lacrime.
Giaco cerca di sfiorarsi di nuovo là sotto per esorcizzare la jella involontaria che gli sto tirando, ma glielo impedisco afferrandogli anche l’altra mano per portarle entrambe sui miei occhi, impedendomi di guardare la morte in faccia.
Eppure, contro ogni previsione, l’aereo prende quota e arriva all’aeroporto JKF di New York sano e salvo.
Dopo aver passato sei giorni meravigliosi a New York in cui ho rischiato di morire assiderata per fare la gnocca poco vestita, e aver visto tutto ciò che potevo vedere – compreso lo scoiattolo che mi ha morso impunemente davanti alla casa in cui è stato girato ‘Io sono leggenda’ – arriva il momento di ripartire.
E giunge l’alba del mio ultimo giorno a New York, perciò è meglio che non rimandi a domani ciò che posso fare solo oggi. Dico tra me affacciandomi alla vetrata della nostra stanza da cui si vede l’insegna della CNN.
Domani vedrò questa città con occhi diversi: avrò il cervello in pappa al pensiero della supposta volante su cui sarò costretta a salire per tornare a casa, quindi è giunto il momento di affogare i dispiaceri nello shopping e di bruciare tutto quello che rimane del mio budget mensile destinato allo shopping.
Dopo tutto mi serve un bel souvenir.
“Giaco, svegliati”, dico battendo le mani.
Lui apre solo l’occhio sinistro, ma è iniettato di sangue e riesco a intendere il messaggio: ‘perché mi stai facendo questo? Sono solo le sei del mattino…’
Anche se non si pronuncia, io rispondo lo stesso: “Il jet lag non mi abbandona, perdonami… e poi è il nostro ultimo giorno a New York – forse anche l’ultimo della nostra vita – non vuoi rendermi felice e farmi un regalo?” gli chiedo sorridendo mentre gli sbaciucchio la fronte.
Giaco si gira dall’altra parte, ma non lo prendo come un no: chi tace acconsente.
Alla fine, il regalo me lo faccio da sola, quando entro in un bellissimo negozio vintage e trovo una giacca di Moschino Cheap and Chic.
Il commesso è simpatico e mi fa pure cinquanta dollari di sconto perché il capo ha una macchia sul polsino.
Esco dal negozio ed è come se avessi comprato un attico a Manhattan.
Anche Giaco apprezza l’acquisto, ma il tramonto di quella lunga e indimenticabile giornata è già arrivato. Torniamo in albergo passeggiando sulla Quinta mano nella mano, ma prima di partire devo dare un’ultima occhiata alla boutique di Chanel.
Quando arriviamo davanti alla vetrina, una borsa mi fulmina. È una bellissima Boy in pelle dorata, la patta ha un effetto a nido d’ape, la chiusura e la catena sono in argento.
“Giaco, guarda questa borsa”, mormoro sognante indicandola.
“Bellissima…”
“La compriamo?” incalzo, ma non gli lascio il tempo di rispondere. “Se domani dovessimo morire, io avrei almeno ricevuto una borsa di Chanel comprata a New York, non è romantico?”
Giaco non si tocca più – non davanti a una vetrina di quel calibro – ma mi guarda divertito.
“E poi”, continuo. “Siamo una società di collezionisti? Sì, quindi se prima ho comprato io, adesso tocca a te.” concludo ironica.
“Pensala così, amore mio: il cambio è troppo svantaggioso per la ‘nostra società di collezionisti’”, precisa virgolettando. “Non sarebbe conveniente comprarla qui, quindi dovrai salvarti su quell’aereo e comprarla in Italia.”
Sarà stato il suo tranello ragionevole o il desiderio di possedere una borsa che, alla fine, non ho mai comprato o, forse, la semplice fortuna, ma io e Giaco siamo tornati a casa.
E dopo aver visto New York, ho perso la paura di volare.
Illustrazione: Valeria Terranova