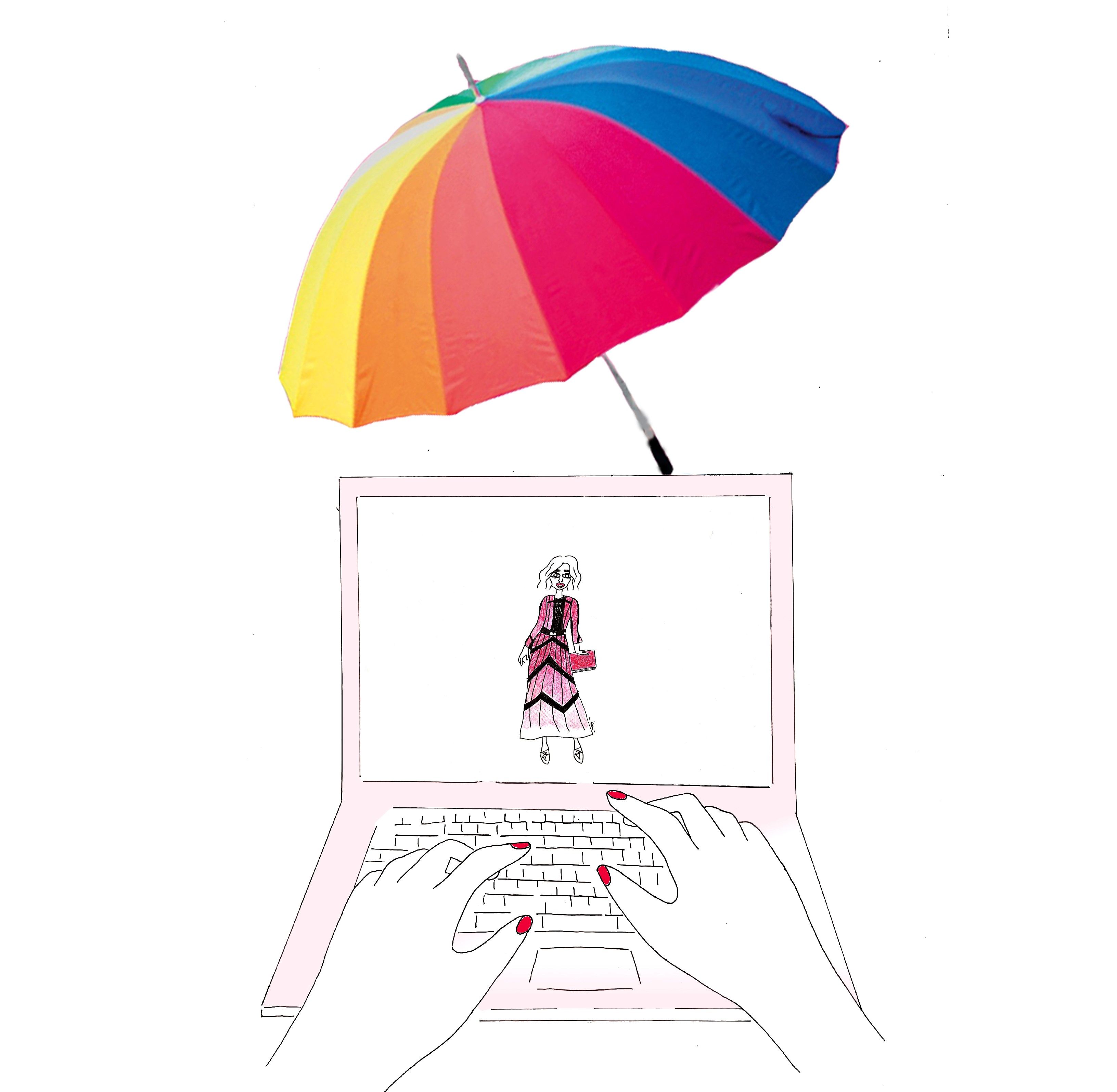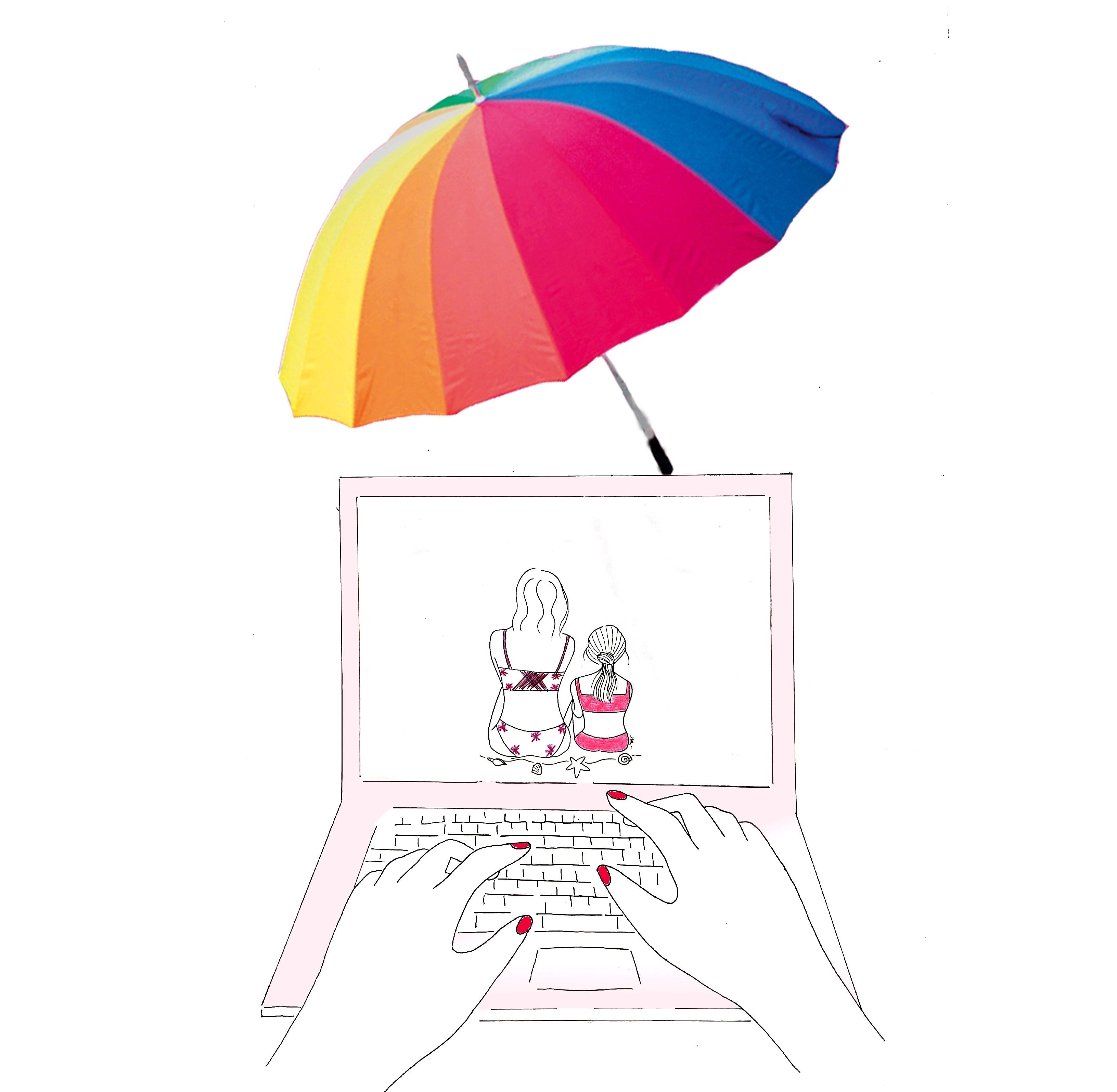l dolore che sarebbe durato per le cinque ore successive – ma forse anche di più – ebbe inizio in una tarda mattina di maggio mentre passavo l’aspirapolvere. I peli del cane rotolavano sul pavimento come le tumbleweeds nelle praterie dei film western, e fino a quel momento erano la mia sola preoccupazione.
Eccolo, ricordo di aver pensato. Quel ciuffo dannato è andato a infilarsi proprio là sotto il divano. «Sei mio!» gli dico mentre mi avvicino tirandomi dietro il tubo molliccio con cui farlo fuori.
Sto per risucchiarlo, ma una fitta improvvisa me lo impedisce. Mi accascio, il dolore è così forte che non riesco a respirare. Non nascerà mica adesso che sto passando l’aspirapolvere?
Continuo a tenerlo stretto con una mano mentre con l’altra apro la finestra cercando di attirare l’attenzione di Giaco, mio marito, che sta di sotto, in giardino, a fumare una sigaretta.
Come sarebbe tutto più poetico se invece di essere qui, mi trovassi sulla baia di Manhattan, e se invece dell’aspirapolvere reggessi la torcia della speranza: in questa posizione potrei quasi sembrare la Statua della Libertà.
Provo a strillare, ma la voce non esce come dovrebbe: mi ricorda il rantolo di Rose mentre chiama Jack ripetutamente, scuotendogli le braccia dopo che il Titanic è affondato. E anche qui nessuna risposta. Dov’è il fischietto?
Non c’è: devo cavarmela da sola.
«Aiuto!» grido alla fine della contrazione.
«Devi cambiare il sacco?» mi chiede Giaco.
Che abbia già capito? Che si stia riferendo a quello amniotico?
Lo guardo bene e dalla sua espressione annoiata capisco che sta parlando dell’aspirapolvere che è ancora acceso.
Do un colpo all’interruttore, quello si spegne e, nel silenzio… la quiete prima della tempesta.
«Enri, muoviti! Lo sai che il lunedì ho i rappresentanti che mi aspettano in ufficio.»
«Giaco è meglio se li avvisi che farai tardi…» gli dico mentre mi accarezzo la pancia.
«Per cambiare un sacco dell’aspirapolvere ci mettiamo un minuto.»
«Ma per fare un figlio ce ne vorranno di più. Ci siamo!»
«Non ci credo…»
Adesso gli tiro l’aspirapolvere dalla finestra: se non si sbriga, rischio di partorire in cucina.
Vado in camera e prendo il trolley che ho preparato un paio di settimane fa. L’ho addirittura etichettato con un cartoncino con scritto: parto.
Quando Giaco lo ha visto, mi ha chiesto dove avessi intenzione di andare all’ultimo mese di gravidanza, e lì ho capito che affidargli una delle mie uova per concepire un bambino, forse, non era stata una buona idea.
Non credo che riuscirò mai a perdonarmi di aver risparmiato quel ciuffo di peli maledetto, mi dico mentre scendo le scale di casa trascinandomi dietro la mia piccola valigia con il nécessaire. Giaco mi raggiunge, la afferra e la carica in macchina.
Io invece mi carico da sola, salgo sul sedile anteriore e tento di allacciarmi la cintura nonostante la pancia ingombrante.
Siamo partiti da un minuto e lui si è già mangiato tutte le unghie della mano destra per la tensione. Dopo aver sputato l’ultima, mi guarda e dice: «Enri… ce la fai?».
«A partorire in macchina?»
Se non altro l’ironia non mi ha abbandonato.
«No, amore mio! Ad arrivare in ospedale.»
«Avevo capito» dico esasperata. «Quanto manca?»
«Resisti ti prego, resisti! Ci vorranno solo cinque minuti.»
Gli uomini: tutti uguali. Cosa non direbbero per salvare la tappezzeria della loro auto?
Leggo il terrore nei suoi occhi ed è strano: dopotutto, sono io a dover fare uscire un bambino dal mio corpo. Sesso forte una cippa, penso. Gli uomini non sopporte-
rebbero neanche la ceretta all’inguine.
Il cicalio dei sensori di parcheggio interrompe le mie considerazioni sul genere maschile, riportandomi alla realtà: proprio davanti all’ingresso dell’ospedale.
«Tesoro, ci siamo!» mi dice.
Giaco mi apre la portiera, mi aiuta a scendere e afferra il trolley.
Lo vedo socchiudere gli occhi: sta cercando di leggere le insegne dei reparti, ma sono troppo distanti. Non si dà per vinto, sospira, tampona il sudore della fronte e accelera il passo. Se non fosse che sono io ad avere la pancia, a vederlo così i dottori potrebbero pensare che è lui ad avere iniziato il travaglio.
«Giaco, stai calmo, vedrai che andrà tutto bene…»
Ripensandoci, l’ultima volta che ho cercato di fargli coraggio con questa frase gli avevano appena rubato la macchina e non è più stata ritrovata.
Mi fermo di colpo: una contrazione fortissima mi impedisce di muovermi.
Stritolo il braccio di mio marito per non gridare, respiro e, per quanto mi sia possibile, accelero il passo verso la porta del reparto maternità che è dritta davanti a me.
Siamo dentro.
Giaco mi abbandona sullo stipite insieme alla valigetta e si mette a correre. Raggiunge la guardiola delle infermiere e grida: «Mia moglie sta per partorire, mia moglie sta per partorire, aiutatela!».
Hai presente quando vorresti sprofondare e fingere di non conoscere la persona che ti sta facendo morire di vergogna?
Bene, quella sono io.
Vorrei fare due passi indietro, uscire dal reparto, uscire dall’ospedale e partorire da sola come un cane, ma la contrazione che è appena arrivata me lo impedisce. Lo guardo da lontano. I miei occhi riescono comunque a fulminarlo. Recupero il trolley, avanzo e lui fa per nascondersi dietro una delle ostetriche che, divertita dalla scena, si avvicina sorridendo.
«Fallo un’altra volta e ti ammazzo!» gli dico.
«Cosa?»
«Di mettermi incinta. Fallo un’altra volta e ti ammazzo!»
Credo che il dolore mi stia rendendo troppo feroce. Ma lui ci è abituato: all’inizio della convivenza, quando l’ho sgamato a bagnare la tazza del water, sono stata anche peggio – e non avevo le contrazioni. Lui mi fissa con un’espres- sione del tipo: guarda che quella notte sapevi benissimo cosa stavamo facendo e hai anche partecipato attivamente.
L’ostetrica sembra già essersi affezionata alla coppia di deficienti che ha di fronte. Mi fa cenno di seguirla mentre mi chiede la data presunta.
«Dopodomani» risponde Giaco al posto mio e, ancora una volta, il mio sguardo lo disintegra.
«Allora ci siamo!» dice lei con una punta di ottimismo.
Avrebbe già dovuto intuirlo dalla mia faccia. Arriviamo in sala travaglio. Mi guardo intorno: un lettino, un apparecchio per il tracciato, una poltrona e un grosso anello di stoffa circolare appeso al soffitto.
So cos’è quell’affare, l’ho visto al corso preparto. Le donne lo afferrano quando sono sfinite dal dolore e non ce la fanno più. Quello che dovrebbe essere un attrezzo con cui farmi coraggio assomiglia più a uno strumento di tortura medievale. Fingo di non vederlo, distolgo lo sguardo e attendo istruzioni.
L’ostetrica mi fa accomodare sulla sedia che sta di fronte alla sua scrivania, le consegno la mia cartella medica e non riesco a staccarle gli occhi di dosso. E non perché ho improvvisamente cambiato il mio orientamento sessuale, ma per il grosso neo a forma di hamburger posizionato sulla sua guancia destra.
È enorme.
«Dunque, la data presunta è il cinque di maggio,» dice dopo aver alzato gli occhi dai fogli «lei come si sente?»
«Ho visto giorni migliori…»
«La faccio accomodare sul lettino per controllare la dilatazione.»
Mi svesto, mi sdraio, divarico le gambe, guardo il soffitto e a quel punto, non posso fare a meno di chiedermi: ma come le sarà cresciuto un neo così grande?
Il mio sguardo rimane fisso verso l’alto, mi accorgo di alcuni puntini e non capisco se siano allucinazioni o difetti dell’intonaco. Provo pure a unirli come nel giochino della «Settimana enigmistica», ma non esce niente.
«È già dilatata di cinque centimetri… bene.»
Bene. Cosa significa bene?
Anche Giaco, che è seduto sulla sedia, ha la faccia di chi non ha capito.
Il soffitto non trova la risposta alla domanda di poco fa, ma me ne suggerisce una nuova, la sola che abbia senso in un momento come questo: «Tra quanto avremo finito?».
«A occhio e croce direi un’ora.»
Be’, se penso alla Via Crucis, mi viene da dire che a Gesù è andata peggio.
L’ostetrica mi chiede di rivestirmi e decide di assegnarmi una camera in reparto.
Non credo che ci sia la possibilità di scegliere tra una deluxe, una superior o una suite.
Non voglio un letto king size, una bella scrivania o una vasca idromassaggio: mi basterebbe uno specchio per capire in che stato sono ridotta.
L’ostetrica apre la porta, mi cede il passo e io entro seguita da Giaco. Le mie preghiere sono state esaudite: c’è uno specchio sull’anta esterna dell’armadio, ma sono meno soddisfatta dell’immagine che vedo riflessa.
Mi consolo pensando che anche Angelina Jolie non dovesse sentirsi un fiore, il giorno del parto.
«Enrica, può cambiarsi, mettersi qualcosa di comodo e raggiungermi in sala travaglio. Se i dolori ricominciano, sono qui fuori» mi raccomanda l’ostetrica mettendomi una mano sulla spalla.
Resto sola con Giaco, anche le contrazioni sembrano averci concesso un momento di privacy, e finalmente potrò sfoggiare la mise che ho preparato per dare alla luce la mia creatura: una lunga camicia da notte in seta bianca di Blumarine, come la vestaglia in coordinato, da completare con un delizioso paio di pantofole nere in raso con inserti in lapin.
Mi guardo allo specchio e con questo nuovo look non sono affatto male.
Come sarebbe bello se ora mio marito mi guardasse con un’espressione traducibile in: “ehi tesoro, sei proprio uno schianto”, ma mentre mi volto per cercare la sua approvazione, lo sorprendo di nuovo a mangiarsi le unghie con gli occhi fissi sul pavimento.
L’ostetrica dà due colpi alla porta socchiusa per avvertirmi che sta entrando, mi guarda da cima a fondo e sorride. Sapevo che almeno lei avrebbe apprezzato.
Ora mi dirà che non capita spesso di vedere delle gestanti così eleganti, io gongolerò e partorirò nel mio look azzeccato senza nessun dolore.
Ma, invece di ricevere la valanga di complimenti che mi aspettavo, questa si avvicina, trattenendo a stento una ri- sata, e dice: «Non crede sia meglio indossare qualcosa di più… scuro?».
Scuro? Ma mi faccia il piacere! Non siamo mica a un funerale.
«Perché?» le chiedo.
«Be’, il travaglio è appena iniziato. Durante la fase espulsiva potrebbe sanguinare e mi dispiacerebbe se rovi- nasse una camicia da notte così bella…»
Sanguinare? Nessuno mi ha mai detto che avrei dovuto sanguinare!
Vorrei rimproverarle la mancanza di delicatezza, ma preferisco salvare la camicia e accettare il suo consiglio. Annuisco, sorrido e mi metto a frugare in valigia cercando qualcosa di più scuro, come da lei suggerito.
Trovato: una camicia a fiorellini rosa.
Nella scala cromatica, il rosa è decisamente più scuro del bianco: sfido chiunque a sostenere il contrario.
Sono qui da cinque minuti e ho già fatto due cambi d’abito – neanche a Sanremo.
E immaginando la lunga scalinata del Teatro Ariston, esco dalla camera con Giaco sotto il braccio e seguo l’ostetrica che mi conduce di nuovo in sala travaglio.
Estratto dal libro